«Filel, aspetta!»
L’uomo si fermò, al limitare dell’accampamento costruito alla bell’e meglio tra le rovine, lasciando che Kal lo raggiungesse.
Ma né lui né la moglie si girarono a guardarlo.
«Perché tornate indietro?»
«Nostro figlio è là.» fu la risposta di Filel.
«Lo sai che non è così. Te l’ho detto.»
«Hai visto il suo corpo?» La sua voce aveva un tono stanco. In questi due giorni era come se fosse invecchiato di quindici anni.
«Filel, è caduto nel fiume…»
«Sì o no?»
Kal sapeva a che punto lui voleva arrivare, ma ormai aveva esaurito i modi per convincerlo: «No, non l’ho visto.»
«E allora esiste la possibilità che sia ancora vivo. E io lo troverò.» riprese lui, come Kal si aspettava. «E anche se lui fosse davvero…» non finì la frase.
Kal fece un ultimo tentativo: «Eumela, diglielo tu. Anche se raggiungete di nuovo le barche e attraversate il fiume, otterrete solo di farvi arrestare, o peggio!»
«Non farmi parlare, Kal.» La donna si voltò verso di lui. «Non voglio rischiare di dire qualcosa di ingiusto, di cui poi mi pentirei.»
Kal vide che il suo viso era rigato di lacrime. Non l’aveva mai vista piangere.
«“Qualcosa di ingiusto”? Cosa vuoi dire?»
Lei non rispose, e si incamminò insieme al marito.
Kal avrebbe voluto fermarli, ma a quel punto capì.
Si stava sforzando di non dare la colpa a me.
Era Kal che gli stava tenendo la mano, quando Mak era caduto. Sarebbe stato comprensibile considerare lui responsabile della sua morte. Se solo lui fosse stato più forte, forse…
Kal scosse la testa. Anche Eumela aveva detto che sarebbe stato ingiusto accusarlo. Se avesse lasciato spazio al senso di colpa, ne sarebbe rimasto schiacciato.
Però non ebbe comunque più la forza per dire nulla alla coppia di genitori in lutto.
Li guardò allontanarsi. Nessun altro cercò di fermarli.
«Se ne sono andati, proprio come aveva detto Kal ieri.» disse Agatha, rientrando in una delle tende che le guardie avevano allestito.
«Non saranno gli ultimi.» disse sua madre cupamente, seduta sulla sua branda. «Molti figli sono rimasti indietro per permettere ai genitori di fuggire. E questi genitori stanno cominciando a capire che non li rivedranno mai più.» L’ultima frase fu accompagnata da un sospiro.
«Ma perché andarsene? Che senso ha? Non c’è più niente per loro a Elis.»
«Forse sentono che non c’è più niente per loro nemmeno qui.»
«Come sarebbe a dire? Non gli importa della loro vita?»
Eleisa Kalina rivolse a sua figlia un sorriso compassionevole: «Agatha, nella nostra vita arriva un momento in cui troviamo qualcosa…» si interruppe, come per cercare le parole «…che è più importante di noi stessi. Da quel momento in poi, noi viviamo per questo ‘qualcosa’. E se esso all’improvviso viene a mancare, con esso perdiamo anche qualsiasi motivo per continuare a vivere.»
«Non capisco. Voglio dire, facciamo un esempio: Papà non c’è più, eppure io… voglio ancora vivere.»
Sì. Una volta raggiunto questo accampamento, quando finalmente aveva avuto il tempo di fermarsi e prendere davvero consapevolezza che non avrebbe mai più rivisto suo padre, Agatha aveva pianto tutte le sue lacrime. Suo padre era una delle persone a cui lei voleva più bene al mondo, ma nonostante la tristezza, lei sentiva di voler continuare a vivere.
«Questo vuol dire che lui… non era il mio ‘qualcosa’.» concluse, sedendosi accanto a sua madre.
«Certo che non lo era.» disse lei, abbracciandola. «Lui era tuo padre. Non funziona così.»
Guardando le sue braccia esili, nessuno al di fuori della famiglia si sarebbe aspettato una stretta tanto forte.
«Per molto tempo, lui fu il mio.» continuò, accarezzandole con tenerezza i capelli. «E se non foste arrivati voi due, forse lo sarebbe stato ancora. Ma dal giorno in cui siete nati, il nostro ‘qualcosa’ siete stati tu e Kal, per entrambi. E sono grata in ogni istante, per il fatto di avervi ancora con me.»
A quel punto sua madre sospirò di nuovo, prima di concludere: «Se solo fossero tutti capaci di provare tale gratitudine…»
Elef guardava il soffitto.
La vista del cielo nuvoloso era bloccata dal tetto di travi scure di uno degli edifici in miglior stato che le guardie avevano trovato tra le rovine.
Fece una smorfia. Le nuvole sarebbero state uno spettacolo meno noioso. E una distrazione più efficace dal dolore.
Si riassestò leggermente sotto le coperte, e anche solo quel movimento gli fece male. Alzarsi e coricarsi faceva male, qualsiasi movimento faceva male, persino respirare faceva male.
Quel giovane medico aveva detto che era un buon segno, voleva dire che la febbre stava scendendo, ed Elef gli credeva.
Ma non era quello il dolore da cui voleva essere distratto.
Se ci fossero distrazioni però, non sarebbe una cella, pensò con amarezza.
Era una cella improvvisata, ma pur sempre una cella. Fuori dall’uscio erano appostate due guardie, con l’ordine di sorvegliarlo ed eventualmente impedirgli di scappare.
Quando era arrivato alle rovine, si erano tutti prodigati per aiutarlo.
«Povero ragazzo!»
«Attenti a non riaprirgli la ferita!»
«Non ti preoccupare, te la caverai!»
Ma i toni erano cambiati l’istante in cui avevano visto il simbolo sulla sua uniforme, il pugno grigio della Seconda Compagnia.
«Un disertore!»
«Quella ferita se la sarà fatta prima o dopo essersela data a gambe?»
«Mio figlio portava quello stesso simbolo! Con che coraggio hai abbandonato a morire lui e tutti gli altri tuoi compagni? Maledetto codardo!»
A pensarci bene, forse le due guardie servivano anche a impedire che qualche cittadino decidesse di “prendere la giustizia nelle proprie mani”. In preda alla rabbia avevano persino tentato di allontanare il medico. Probabilmente in questo momento era la persona più odiata dell’intero accampamento.
Ma non era nemmeno questo il dolore da cui Elef avrebbe voluto fuggire.
Ciò che lo tormentava davvero era l’aver visto i suoi genitori, in disparte, lontano dalla folla. Il loro sguardo di indifferenza, di velato disgusto e delusione, e il modo in cui avevano reagito quando tra la folla uno aveva detto: «Ehi! Sbaglio o questo è vostro figlio?»
«Ti sbagli.» aveva detto suo padre. «Non ho idea di chi sia quel ragazzo.»
«Nostro figlio è morto a Elis.» aveva detto sua madre. «Lasciateci in pace.»
Sentì che i suoi due colleghi stavano discutendo con qualcuno. Dopo un paio di scambi di parole, una persona entrò nella cella.
Elef non si voltò a guardare chi fosse. Girò anzi la testa dall’altro lato, a costo di una fitta di dolore.
«Elef.» la voce di sua madre. «Sono io. Ti prego, guardami.»
Lui non obbedì.
«Lo so che sei arrabbiato, è comprensibile. Mi dispiace per quello che ho detto quattro giorni fa, dico davvero.»
In realtà Elef non provava rabbia. Si sentiva solo… stanco.
«Però, devi capire. C’era tutta quella folla furiosa, ho avuto paura. Ho anche i tuoi fratellini a cui pensare. Cosa ne sarebbe di loro se mi succedesse qualcosa?»
Il giovane non rispose.
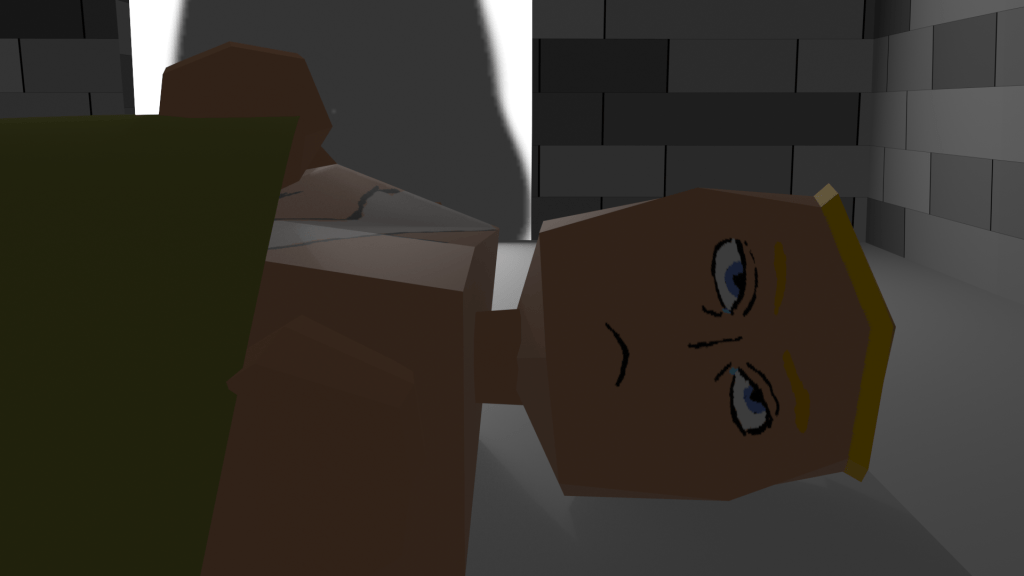
«E poi, beh, lo sai com’è fatto tuo padre, no? Lui voleva tanto che tu facessi carriera, perché così avresti riscattato anche lui. Aveva dei piani per te, e adesso tu… voglio dire, sono stati tutti rovinati.»
Elef non riuscì a impedirsi di avere un tremito.
«Se fosse per lui, dovremmo tutti dimenticarci di te.» continuò lei. «Ma io, io sono contenta anche solo che tu sia ancora vivo.»
Sentì una mano accarezzargli la spalla.
«Vedrai, andrà tutto bene. La gente si calmerà, e prima o poi anche tuo padre cambierà idea. E quando accadrà, festeggeremo di nuovo tutti insieme.»
La persona si alzò e uscì.
Elef rimase immobile. Provava una bizzarra sensazione, come se avesse già sentito quelle parole.
Perché era proprio così.
Erano quasi le stesse che gli aveva detto suo padre il giorno prima.
«Elef, sii comprensivo, cosa avrei dovuto fare? Quella folla ci avrebbe fatti a pezzi. E a quel punto cosa ne sarebbe stato dei tuoi fratellini? E poi, lo sappiamo tutti e due come è fatta tua madre. La vita che facciamo, tra la città e la campagna, le è sempre stata stretta. Aveva riposto in te tutte le sue speranze di entrare nell’alta società e adesso tu… beh, dal suo punto di vista è stato tutto tempo sprecato. Per lei, tu non esisti più. Se venisse a sapere che sono venuto a farti visita, oh, non oso pensare a quanto si arrabbierebbe! Ma io, io sono felice anche solo di vederti ancora vivo. Vedrai, si sistemerà tutto. Non possono restare arrabbiati per sempre, né tua madre né gli altri cittadini. E quando gli sarà passato, faremo una bella festa, tu, io, la Mamma e tutti quanti. Che ne dici, eh?»
Elef chiuse gli occhi, stufo di guardare quel soffitto scuro o quelle mura grigie.
Ed evitando il più possibile di farsi sentire, si mise a piangere.
«Siamo fermi già da quasi una settimana.» le disse il capitano Astor.«I cittadini si stanno facendo irrequieti, e le provviste continuano a diminuire. Se vogliamo arrivare ad Istak dobbiamo partire adesso!»
«Hai visto in che condizioni è mio padre? Non possiamo muoverci finché non si sarà ripreso.» rispose Helena. Era stufa di discutere con lui. Ogni giorno veniva a dire le stesse cose, come se lei non le sapesse già.
«Sono in grado di parlare per conto mio, Helena.» disse suo padre, dal suo letto. Nonostante il tentativo di dissimularlo, la sua voce era roca e affaticata.
Lei posò lo sguardo su di lui, e se ne pentì. Ogni giorno il suo colorito diventava più pallido, le sue occhiaie più profonde.
«Sì, per ora. Ma se insisterai nel farlo tarderai ancora di più a guarire. Devi solo pensare a riposare.»
«Helena, ascoltami…» la frase si interruppe con un gemito.
«Non provare ad alzarti! Maledizione, dobbiamo cambiarti le fasciature! Ergon, devo pensare io a tutto o vuoi renderti utile?!»
«Subito.» L’uomo apostrofato si mise immediatamente al lavoro, con grande sollievo di Helena. Lei non avrebbe avuto il coraggio di guardare la ferita di suo padre, che si ostinava a non guarire.
«Se mi è permesso, Helena Dorina,» disse Ergon all’improvviso, mentre lavorava con precisione, «da quanto tempo è che non dormi? Anche la tua salute è importante.»
Qualcosa nel tono tranquillo dell’attendente di suo padre la irritò. Era conscia che quello era solo un altro sintomo della propria mancanza di sonno, eppure non riuscì a impedirsi di ribattere: «Invece di pensare a me, perché non pensi anche tu al tuo esarca? Come mai le tue medicine non stanno funzionando?»
«Le mie medicine stanno funzionando, Helena Dorina.» rispose lui, con la stessa tranquillità di prima, senza smettere di sistemare le fasciature del suo paziente. «Come hanno funzionato su quel ragazzo ferito che è arrivato qui cinque giorni fa. Ma nel caso di tuo padre, la ferita è molto più profonda, e vicina a molti organi vitali. Sto facendo quello che posso.»
«Se quello che puoi non sarà abbastanza…»
«Helena, basta così!» suo padre si mise seduto sul letto. «Hai ragione, in questo momento non sono in grado di viaggiare. Ma ha ragione anche Astor, non possiamo restare fermi qui ancora a lungo. Abbiamo una missione da compiere.»
Helena sapeva che lui avrebbe detto così.
«Lo faremo.» gli disse. «Ma prima tu devi riprenderti, capisci? Non puoi…»
Non puoi lasciarmi sola.
«Vedrai, in due giorni mi sarò ripreso abbastanza. E tra due giorni partiremo. Possiamo permetterci questi due giorni, Astor?»
Il capitano della Prima Compagnia rimase interdetto per un istante, visibilmente in imbarazzo, poi rispose: «Sì, credo di sì.»
«Perfetto, allora.» Suo padre sorrise, prima di rivolgersi di nuovo a lei. «La mia è una promessa, Helena. In cambio di questa promessa, tu adesso devi andarti a riposare. D’accordo?»
Helena non riuscì a mettersi a discutere. Sentì che stava per piangere, ma si controllò. Disse solo «Va bene, Padre.» e uscì, seguita dal capitano.
Nel momento in cui fu uscita dalla stanza, all’improvviso tutte le sue forze vennero meno. Non si era resa conto di quanto fosse stanca.
Fortunatamente Astor le impedì di crollare a terra, e la accompagnò fino alle sue stanze, dove lei si coricò, addormentandosi immediatamente.
Post Scriptum
Se avete seguito i capitoli delle ultime settimane, probabilmente avete qualche domanda sulle illustrazioni che sono comparse senza preavviso.
Io avevo intenzione sin dall’inizio di accompagnare il testo a delle immagini, ma ho dovuto affrontare un grosso ostacolo:
non so disegnare.
Anzi, sarò più onesto: disegnare non mi diverte quanto scrivere.
Così… ho dovuto servirmi di una tecnica che a molti farà storcere il naso.
Lo so, è considerato “barare”, è un modo “pigro” di approcciarsi all’arte, ha sconvolto il settore con il suo arrivo tempo fa, e credetemi non ho nessuna intenzione di considerarmi “artista” dopo essermi abbassato a tanto, però…
Sì, sto usando modelli 3D.
Spero riusciate a perdonarmi.
E se vi piace quello che leggete, e magari anche le figure che vedete, parlatene comunque con i vostri amici!
Leave a comment